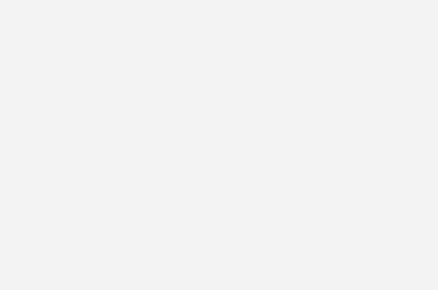Tra procedure, adempimento e carico fiscale le imprese non riescono a tornare a crescere. A prevalere sarà probabilmente lo “statalismo autoreferenziale”, in sostanza: tante belle parole e pochi fatti
Della zavorra della burocrazie si è discusso al Censis durante il tradizionale appuntamento “un mese di sociale” dedicato quest’anno al tema “Rivedere i fondamentali della società italiana”. L’incontro di riflessione del 17 giugno ha avuto come titolo “A difesa del privato” e ne è emersa la conferma di ciò che tutte le imprenditrici e gli imprenditori pensano: l’eccesso di regole, l’eccesso di tasse, l’eccesso di adempimenti collegato a una burocrazia inefficiente non fanno altro che soffocare l’iniziativa privata e non permettere la ripresa economica del nostro Paese, a prescindere dalle tante belle parole sui “segnali di ripresa” e sulla – ancor più fantomatica – “uscita dalla recessione”.
Dovendo scegliere tra 15 fattori che ostacolano lo sviluppo delle imprese, il 19,9% degli imprenditori italiani colloca al primo posto la burocrazia statale inefficiente come principale zavorra per chi vuole avviare un’attività economica. Si tratta di una percentuale molto più alta rispetto agli altri grandi Paesi europei: l’8,5% nel Regno Unito, l’8,9% in Germania, il 10,3% in Francia.
Al secondo posto gli imprenditori italiani citano l’eccessivo carico fiscale (18,7%), molto più dei loro colleghi tedeschi (10,9%), inglesi (12,8%), spagnoli (12,8%).
Gli effetti del cattivo funzionamento della macchina pubblica sono evidenti se si guarda la nostra capacità di spendere i fondi europei della programmazione 2007-2013: a un anno dal termine ultimo, la spesa certificata è di 33 miliardi di euro, ovvero il 71% di quanto programmato. Questo significa che bisognerebbe spendere entro l’anno i residui 13,6 miliardi di euro, oltre 10 miliardi dei quali riguardano le regioni meridionali. Ce ne sarebbe bisogno? Altroché, ma la burocrazia non permette alle imprese di avvicinarsi a questi fondi, visti i meccanismi “arzigogolati” partoriti da menti machiavelliche sembrerebbe proprio allo scopo di non farli utilizzare. Nonostante si continui a parlare di semplificazione, diciamolo chiaramente: in Italia di semplice non c’è un bel niente.
Lo stesso Censis dice che è “un’impresa fare impresa”.
Nell’analisi prodotta, risulta chiaro che il contesto internazionale è oggi favorevole alla ripresa economica, ma la chimica interna del nostro sistema rischia di stoppare tutto.
Nella graduatoria mondiale della World Bank, l’Italia si colloca al 56° posto su 165 Paesi per facilità di fare impresa. Per ottenere un permesso edilizio per costruire un capannone, nel nostro Paese servono mediamente 233 giorni (quasi 8 mesi), con un costo delle procedure che arriva fino a quasi il 4% del valore dell’investimento. Per ottenere la stessa autorizzazione, in Germania bastano 96 giorni, 105 nel Regno Unito, 183 in Francia.
Per allacciarsi alla rete elettrica, in Italia sono necessari in media 124 giorni: solo 28 in Germania, 79 in Francia, 85 in Spagna.
Burocrazia e scarsa trasparenza generano poi un contenzioso complesso e costoso. L’Italia si colloca al 147° posto su 180 Paesi nella graduatoria mondiale relativa alla risoluzione delle controversie commerciali, lontanissima dalla prima posizione di Singapore e più vicina alle performance di Trinidad e Tobago, distante anche da tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea, con l’unica eccezione della Grecia.
Per risolvere una controversia commerciale bisogna passare attraverso 37 procedure e servono in media 1.185 giorni (circa 3 anni e 3 mesi), contro i 394 giorni della Germania, i 395 della Francia, i 437 del Regno Unito, i 510 della Spagna. Peggio di noi in Europa solo Slovenia (1.270 giorni necessari in media per risolvere una causa commerciale) e Grecia (1.580 giorni).
E che dire del fisco? Un altro problema che limita la crescita delle nostre imprese, spingendole spesso all’evasione, è il carico fiscale e gli adempimenti burocratici connessi. Le imprese in regola con le tasse in Italia dedicano in media 269 ore all’anno (circa 34 giorni) agli adempimenti necessari per pagare le imposte, contro 110 ore necessarie nel Regno Unito, 137 in Francia, 218 in Germania.
E sono sottoposte a un carico fiscale che è pari al 65,4% dei profitti realizzati, contro il 33,7% del Regno Unito, il 48,8% della Germania, il 58,2% della Spagna.
Nel nostro Paese pesano particolarmente le imposte sul lavoro, che raggiungono il 43,4% del totale dei profitti (l’11,3% nel Regno Unito, il 21,2% in Germania, il 35,7% in Spagna).
Una volta esisteva in Russia, per una volta intendiamo l’Ottocento, ma oggi esiste in Italia: parliamo del capitalismo di Stato. Contro le nostre imprese private c’è infatti la concorrenza “sleale” dello Stato, che risponde alla politica e non ha inaugurato una nuova stagione di economia mista. Sono più di 11.000 i soggetti economici a partecipazione pubblica, di cui oltre 7.600 aziende (di queste, quasi il 60% con una quota di partecipazione pubblica superiore al 50% del capitale) che impiegano circa 950.000 addetti. Tra le prime 15 società italiane per fatturato, sono 6 a essere a preminente partecipazione pubblica, per un fatturato complessivo che supera i 260 miliardi di euro e corrisponde a più della metà (il 55,7%) del fatturato totale delle 15 maggiori aziende del Paese. Ma negare la dignità del privato come protagonista di attività di interesse collettivo significa scoraggiare una ripresa interpretata da milioni di persone e non solo dalla onnipresenza pubblica. Con il rischio del prevalere di uno statalismo autoreferenziale, burocratico, senza visione e senza capacità di collegarsi con le dinamiche della realtà sociale.
E ora il tasto dolente: la corruzione. Ulteriore fattore frenante per la nostra economia, nonostante gli interventi di controllo e repressione, continua a essere percepita come dilagante. In realtà, se si parla con gli imprenditori, si capisce che il termine corruzione è usato a sproposito, per ignoranza: non sono loro infatti a corrompere ma è chi ha il potere di dare o negare un’autorizzazione a chiedere il denaro e questo legalmente si chiama concussione.
Secondo l’indice di Transparency International, l’Italia si posiziona al 69° posto su 175 Paesi per corruzione pubblica percepita, ultima tra i Paesi europei insieme a Grecia, Bulgaria e Romania.
Per fare un esempio prendiamo il caso degli appalti pubblici. Che la sola via giudiziaria alla legalità – ogni volta riconfermata dagli scandali – non sia sufficiente per contrastare la corruzione lo dimostrano i dati su quelli assegnati con procedura negoziata. Pur essendo una procedura formalmente corretta, dovrebbe però essere usata in via eccezionale e con adeguata motivazione. Invece, tra il 2011 e il 2014, è stata utilizzata nell’81% degli affidamenti dei 20 Comuni capoluogo (più di 36.000 volte). Cosa c’è di strano? Che si tratta di un escamotage per non bandire una gara aperta, spesso ricercato per non rimanere impelagati in procedure lunghe e farraginose, che è stato utilizzato soprattutto per i contratti di pezzatura minore (l’importo medio è di 115.000 euro, ben oltre la soglia dei 40.000 euro consentiti per gli affidamenti diretti), ma che ha riguardato contratti per un valore complessivo di 4,2 miliardi di euro stipulati dai Comuni capoluogo negli ultimi quattro anni. Si può stimare in 33 miliardi di euro l’anno il valore dei contratti pubblici sopra la soglia dei 40.000 euro stipulati a livello nazionale con procedura negoziata.
Crediamo insomma che ci sia bisogno di qualcosa di più che non i bei proclami sul quanto stiamo bene, su come stiamo uscendo dalla crisi, sulla ripresa economica, ecc. In Italia infatti non sembra affatto così perché i nostri “antichi mali” ancora non sono stati stroncati e continuano a mietere vittime nella classe dei lavoratori e degli investitori privati, ovvero le aziende, che danno il lavoro ma che – andando avanti così – non potranno continuare a farlo. Possibile che non si capisca?