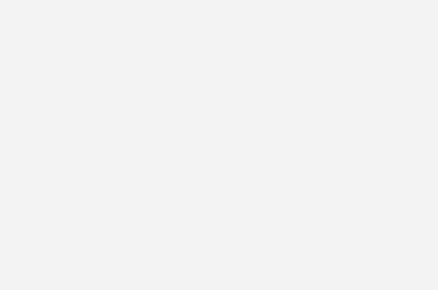Hannah Arendt: per non dimenticare “la banalità del male”
Celebrata in tutta Italia la Giornata della Memoria: canale privilegiato il cinema, che offre al grande pubblico chiavi di lettura al femminile
“Meditate che questo è stato”. Così tuonava Primo Levi, nella sfraghìs del suo nobilissimo volume-memoria sulla shoah, dal titolo provocatorio: “Se questo è un uomo”…
E insisteva con struggente lucidità sulla dimensione disumanizzante dell’olocausto, sulla capacità che l’operazione nazista, nella sua cieca violenza, ebbe di colpire l’uomo nella sua dignità, rendendolo inutile, dandogli anzi la percezione e l’assuefazione ad essere inutile, e mortificandolo in tutte le sue funzioni, vitali, intellettive e operative che fossero. “Rendere l’uomo superfluo: in questo riuscì la barbarie più terribile di tutti i tempi, e per questo si trattò di un crimine contro l’umanità intera, e non soltanto contro gli Ebrei”. È la risposta, incredibilmente vicina alla lettura del grande scrittore italiano sopravvissuto ad Auschwitz, che Hannah Arendt fornisce all’obiezione di una sua giovane studentessa, a New York, un mattino di inverno del 1962: ed è la chiave di un film intenso, difficile, che medita sul problema del male ed investe l’olocausto non in maniera frontale, ma attraverso la riflessione e il pensiero di una delle filosofe più acute e contestate del secolo scorso.
In Italia la giornata della memoria si è celebrata anche così, con la diffusione nelle sale, per soli due giorni, della pellicola di Margarethe Von Trotta uscita l’anno scorso, girata con la sceneggiatura attenta di Pam Katz e l’interpretazione di un’intensissima Barbara Sukova, attrice prediletta della regista, già impegnata altre volte a raccontare storie di donne, e tornata con questo film a riflettere sul tema della shoah.
Un film rimasto in lingua originale, che si districa tra inglese, tedesco e qualche parola di ebraico, mai doppiato in italiano e mai portato nei nostri cinema prima di adesso perché considerazioni di marketing lo hanno sconsigliato. Eppure, a dispetto di chi ha giudicato forse troppo sbrigativamente il pubblico dello Stivale, le sale erano piene, le sere del 27 e del 28 gennaio, e i cinema hanno triplicato gli spettacoli per far fronte alle richieste: e questo film, tutto parlato e pensato, eppure incredibilmente poetico, andrebbe doppiato, diffuso e discusso, perché farebbe crescere.
Crescere attraverso il pensiero, che è dialogo con se stessi: perché, ammonisce la Arendt, è proprio l’incapacità di pensare, cosa ben diversa dall’essere stupidi, che produce “il male più grande, quello commesso dai nessuno”, da quanti cioè abdicano alla propria facoltà di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato e di valutare autonomamente, e si adattano di buon grado, acriticamente, alle decisioni di altri o al pensiero dominante. Lo diceva già Dante nel De Monarchia, settecento anni fa, discutendo di libero arbitrio con accenti di una modernità disarmante: “prima la cosa è appresa; poi, appresa che sia, viene giudicata buona o cattiva; infine, dopo averla giudicata, uno la desidera o la fugge”. E però, se manca il giudizio su cosa sia buono e cosa sia cattivo, o se questo giudizio è demandato ad altri, e se il desiderio e l’azione non passano per il vaglio della ragione di chi desidera o agisce, ma eseguono gli ordini di altri senza pensare, l’arbitrio da libero diventa schiavo, lo stesso esercizio della responsabilità diventa aleatorio, non si può parlare di scelte, e non c’è modo di essere consapevoli delle azioni che si compiono.
Questa è, per la Arendt, “la banalità del male”: perchè a differenza del bene, che può essere radicale in quanto sempre ha radici profonde, il male non ne ha mai, si insinua in una società attraverso la mentalità dominante e si realizza per l’intervento di uomini insignificanti, meschini e privi di autonomia, che non si sentono responsabili delle azioni che hanno compiuto, ma si limitano ad essere ingranaggi di un meccanismo. Ciò che fu, a suo avviso, Adolf Eichmann, l’ufficiale nazista condannato all’impiccagione per crimini contro l’umanità, il cui processo, svoltosi a Gerusalemme nel biennio ’61-’62, la Arendt seguì in prima persona in qualità di reporter per il New Yorker. E lì, osservando e ascoltando le deposizioni dell’uomo, recuperate nel film in originale, direttamente dal documentario in bianco e nero che diffuse il processo nelle televisioni di tutto il mondo, la filosofa ebrea maturò l’intuizione, profondissima e disarmante, che confluì prima nel lungo articolo sull’evento e poi nel suo volume più famoso: intuizione, quella de “La banalità del male”, capace di minare alla radice ogni lettura dell’olocausto come male assoluto compiuto da esseri malvagi, per dichiararlo espressione della gregarietà di uomini normalissimi, per i quali l’essere ligi al dovere e il rispettare gli ordini ricevuti precedevano ogni senso di umanità e ogni idea adulta di responsabilità personale. Non uomini diabolici, pertanto, ma uomini che si possono incontrare tutti i giorni, nei quali da tempo tace la coscienza, divenuta incapace di individuare, nelle azioni che vengono compiute, il significato e l’obiettivo ultimo. Una coscienza intrappolata nel contingente, nella ripetizione di atti privi di anima e privi di storia, senza un passato e senza un futuro, asfittici e chiusi in se stessi: tale era, ad esempio, il riempire i vagoni e chiudere le porte di un treno diretto ad Auschwitz, compito precipuo di Eichmann negli anni del suo servizio nelle SS. Lì il suo ruolo si esauriva, il resto toccava ad altri, e ciò bastava a fargli credere di non aver “mai torto un capello a un ebreo”, di aver “solo eseguito gli ordini emessi da una organizzazione gerarchica”.
Questa, la tragedia che si consumò con la shoah, tragedia dell’assenza di radici e di progetto, tragedia delle vittime e dei carnefici, le une costrette, gli altri condannati alla stessa inutilità ultima: e questa tragedia seppe leggere Hannah, con una sensibilità tutta femminile, e con un pensiero capace di snidare il male oscuro che distrugge l’individuo, quando gli sottrae la capacità di riconoscere le proprie colpe e di assumere la responsabilità, e lo fa sentire un meccanismo senz’anima. Questa la tragedia intuita e narrata da una donna che aveva conosciuto gli orrori dei campi di internamento, le restrizioni del regime nazista e la condizione di apolide, e che aveva negli stessi anni assaporato la vita con tutta la sua immensa bellezza, le gioie dell’amore, l’invaghimento per il grande maestro Martin Heidegger, la delusione scoprendolo vicino al nazismo, i piaceri alti e silenziosi della filosofia, i due matrimoni, le sincere e viscerali amicizie, la passione e il desiderio di capire, di elaborare il dramma incomprensibile che aveva colpito la sua epoca, la sua vita e il suo popolo. Una donna descritta in fondo nella sua quotidianità di moglie, docente, amica e perfino fumatrice, in niente diversa, all’apparenza, da altre mille donne: capace però di ammonire, con la sua storia coraggiosa, a pensare con la propria testa, a restare fuori dagli schemi, a non sentirsi mai immuni dal male subdolo che si insinua nelle pieghe della storia mentre sonnecchiano la ragione e il cuore.
Laura Carmen Paladino